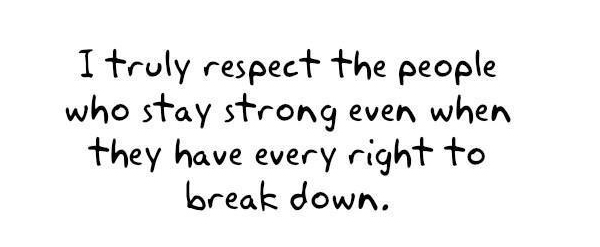Il peggior caffè della mia vita l’ho bevuto il 22 dicembre scorso nell’astanteria del pronto soccorso del Policlinico di Milano. Servito in un piatto di plastica, uno di quelli che al supermercato compri in pacchi da 100, era d’orzo e pareva più che altro una zuppa insapore. Rappresentava il 50% della mia colazione: l’altra metà consisteva in due (e dico due) fette biscottate che al solo tenerle tra le dita diventavano polvere finissima. La colazione dei campioni in pratica, consumata in un luogo che mai avrei voluto vivere, tantomeno come protagonista, tantomeno tre giorni prima di Natale.
Tutto è cominciato la sera precedente quando un calo di pressione (cosa per me assolutamente – purtroppo – nella norma) mi ha trasformata in un albero cadente umano: tentando invano di raggiungere un luogo appartato (ero a una festa) dove potermi accasciare in solitudine e cercare di ripigliarmi come solo anni di svenimenti in luoghi affollati mi hanno insegnato, sono caduta all’indietro tipo albero, rigida tipo cadavere, producendo un rumore che mi ha ridestata e procurandomi una (piccola) ferita alla testa seguita da un classico del Natale 2012, il trauma cranico.
Sirene d’ambulanza, un volontario del 118 niente male, il mio panico, le mie lacrime, il mio parlare a macchinetta causa ansia e la corsa all’ospedale è tutto quello che è avvenuto nell’ora successiva.
Faccio quindi il mio trionfale ingresso al pronto soccorso del Policlinico alle 22:32: mi accolgono immediatamente, mi parlano, mi provano la pressione, mi medicano (il tutto in 20 secondi netti) e deducono che poi così male non sto. Codice verde e attesa in corridoio insieme ad altri, penso io sdraiata e in grado di vedere solo cosa stava sopra di me, pazienti.
Ovviamente mi sbagliavo: la vita è davvero tutta una questione di punti di vista. Se sei al pronto soccorso, su una barella, col collare, la testa fasciata, una fifa blu e un’ipocondria galoppante, immagini, non potendolo vedere, che anche chi ti sta accanto, in attesa, abbia una qualche esigenza del tuo stesso genere. Se non è una botta alla testa sarà una gamba fratturata, un mal di pancia preoccupante, ecc. ecc. E invece no.
Perché il pronto soccorso è un luogo vissuto da gente insospettabile che Fellini ci avrebbe fatto un film (o forse l’ha fatto davvero) e un posto dove tu diventi un numero, un corpo e smetti di essere (per gli altri) una persona.
Capiamoci: io male mi sono fatta male, svenuta sono svenuta e uno spavento me lo sono preso. Ma sono qui a scrivere, ho ripreso a fare una vita normale (ma più tranquilla di prima, per ora) e quindi sono tra i fortunati tra gli sfortunati, quelli a cui capita di aver vissuto un’emergenza, ma solo di striscio e senza conseguenze rilevanti. Scrivo questo perché so che là fuori c’è chi male ci sta per davvero e forse di essere solo un corpo e non una persona non è cosa che lo sconvolge più di tanto perché l’importante è guarire. Punto.
Sono stata ‘rinchiusa’ lì dentro in osservazione e in attesa degli esiti degli esami che mi hanno fatto per 14 ore. Avrei dovuto dormire, ma non ce l’ho fatta: la barella è scomoda, se hai un collarino lo diventa ancora di più, se non ti danno una coperta per coprirti ma ti devi arrabattare con il tuo parka diventa ancora più complicato, se non spengono le luci, se medici, infermieri e personale assistenziale parla alle 3 di notte con il tono di voce delle 4 di pomeriggio sulla spiaggia di Riccione, il 15 di agosto durante una partitella a beach volley, se la tua vicina di letto (ops di barella) non fa altro che sputare sangue, se quello alla tua sinistra invece dorme russando come se non ci fosse un domani, se il vecchietto dall’altra parte della stanza elemosina (inutilmente) urlando un bicchiere d’acqua e se il suo vicino parla con la moglie posizionata in corridoio ovviamente sbraitando per farsi sentire, beh, credetemi, dormire non è possibile. Tanto più che per rendere tutto più facile ti hanno detto che dormire dopo un trauma cranico può essere pericoloso. No, niente, zero, non dormi e manco ci provi.
Allora scopri che il pronto soccorso, più che l’ospedale, è davvero un mondo a parte dove regole, decisioni, atteggiamenti vengono dettati credo più dalla disperazione che da altro. Il lavoro di medici, infermieri e personale assistenziale è difficile ed è pesante. Hai a che fare con centinaia di persone diverse, la maggior parte delle quali spaventate, forse spesso nemmeno troppo accomodanti perché quando stai male te ne fotti dei modi e l’istinto di sopravvivenza prende il sopravvento.
Ho assistito a tre cambi turno (quando sono arrivata se ne andava del personale e ne arrivava dell’altro, quando la mattina alle 7 ci hanno tirato giù dalla barella per il giro visite c’è stato un altro cambio turno) e conto su due dita di una mano chi è stato gentile con me. Che persona gentile non significa persona simpatica, ma semplicemente persona che si è rivolta al mio essere trattandomi come una persona. Rassicurandomi senza essere materno, parlandomi chiaro senza trattarmi da rincoglionita, aiutandomi senza considerare le mie richieste (che, nell’ordine sono state: abbassarmi lo schienale della barella e accompagnarmi una volta a fare la pipì) un peso per l’intera umanità.
Perché lì dentro rischi a un certo punto di sentirti una mezza demente: ti domandi se sbagli a informarti sul tuo stato di salute, se chiedere un bicchiere d’acqua è forse troppo e se non aver voglia di essere sbattuta in sala d’aspetto insieme allo schifo lasciato da chi ci è passato durante l’intera notte è forse un comportamento da fighetta borghese.
Poi arrivi a casa, razionalizzi, ti incazzi e ti confronti con chi questa esperienza l’ha già vissuta e, a parte casi rari, capisci che questa sensazione non è solo tua e che sti cazzi sei sempre un essere umano e che forse soprattutto nei momenti per te più difficili un modo di fare educato (lasciamo perdere simpatia, empatia, rassicurazione e presenza ‘vera’), una considerazione del tuo corpo come se fosse quello di, toh, una PERSONA, non guasterebbe. Perché è vero che tu lì dentro ci finisci perché è il tuo corpo che in qualche modo si è rotto, ma è anche vero che senza di te il tuo corpo sarebbe nulla e viceversa.
Detto questo: a casa ci sono tornata sulle mie gambe dopo aver rischiato un altro svenimento per aver scoperto, quando me la toglievano, in cosa consiste la farfallina che ti infilano in vena (lo so, sono una schiappa!). E nonostante la mia scarsa considerazione dell’atteggiamento che chi lavora lì dentro ha adottato non tanto nei miei confronti, quanto in quelli di chi stava peggio di me e che, per una questione culturale o di età aveva meno strumenti rispetto alla sottoscritta per destreggiarsi nelle cose in modo autonomo, capisco quanto il lavoro di queste persone sia importante e non abbia assolutamente niente a che fare con quello che io considero ‘lavoro’. Se una volta mi dimentico di postare un post su Facebook cosa mai potrà succedere? Posso dire con assoluta certezza “niente”. E così una volta di più mi autoricordo che fortunamente non salvo vite umane e che ‘sta cosa dovrebbero capirla pure tanti altri :).
Ah sì altre due cose: ero truccata con prodotti Dior.. hanno retto mille lacrime e per ben quasi 24 ore senza ritocco alcuno. Uscita al pronto soccorso, ancora sconvolta, mezza scioccata e senza sonno da almeno 30 ore ero ancora piuttosto presentabile.
E se per caso vi state chiedendo del caffè.. l’ho bevuto dal piatto, tipo cane, perché al Policlinico stanno ‘tagliando’ e i soldi per i bicchierini non ci sono più.